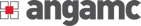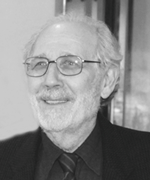
Artista concettuale e pittore - ma anche poeta, scrittore, drammaturgo e regista - Emilio Isgrò (Barcellona di Sicilia, 1937) è sicuramente uno dei nomi dell’arte italiana più conosciuti e prestigiosi a livello internazionale a cavallo tra XX e XXI secolo. Isgrò ha, infatti, dato vita a un’opera tra le più rivoluzionarie e originali nell’ambito delle cosiddette seconde Avanguardie degli anni Sessanta, che gli ha valso diverse partecipazioni alla Biennale di Venezia (1972, 1978, 1986, 1993) e il primo premio alla Biennale di San Paolo (1977). Nel 1965 pubblica Uomini & Donne per Sampietro Editore e l’anno successivo L’età della ginnastica per Mondadori. Nel 1966 tiene la prima mostra personale alla Galleria 1+1 di Padova. Rilascia la dichiarazione di poetica “Descrizione 1” in occasione della mostra presso la Galleria Il Traghetto di Venezia. Alla fine del decennio espone nelle principali gallerie milanesi: Galleria Apollinaire (1968), Galleria del Naviglio (1969), Galleria Schwarz (1970). Nel 1972 è invitato alla XXXVI Biennale d’Arte di Venezia. Nel 1976 il Csac di Parma gli dedica una ricca antologica. Nel 1977 vince il primo premio alla XIV Biennale d’Arte di San Paolo del Brasile. Nel 1978 partecipa alla XXXVIII Biennale d’Arte di Venezia. Nel 1979, alla milanese Rotonda della Besana, presenta l’installazione per 15 pianoforti Chopin, ripreso nel 2001 dalla pianista americana Ophra Yerushalmi alla Guild Hall di East Hampton negli Sati Uniti. Nel triennio 1983-1985 pubblica con Feltrinelli la tragedia L’Orestea di Gibellina. Nel 1985 per l’Anno Europeo della Musica realizza su commissione del Teatro alla Scala gli commissiona l’installazione multimediale La veglia di Bach, allestita nella Chiesa di San Carpoforo. Nel 1986 realizza L’ora italiana per il Museo Civico Archeologico di Bologna, in memoria delle vittime della strage alla stazione ferroviaria. E’ tra i partecipanti alla XLII Biennale d’Arte di Venezia. Nel 1987 l’Istituto Italiano di Cultura a Madrid ospita l’antologica “Cancellature 1965-1987”. Nel 1989 esce da Mondadori il romanzo Polifemo. Nel 1990 elabora un nuovo testo teorico dal titolo “Teoria della cancellatura” per la personale alla Galleria Fonte d’Abisso di Milano. Espone al MoMA di New York nel 1992 in occasione della mostra The Artist and the Book in Twentieth-Century Italy e nel 1994 alla Fondazione Peggy Guggenheim di Venezia per I libri d’artista italiani del Novecento. Del 1998 è il gigantesco Seme d’arancia, donato alla città natale Barcellona Pozzo di Gotto come simbolo di rinascita sociale e civile per i paesi del Mediterraneo. Nel 2001 la Città di Palermo gli dedica una ricca antologica nella chiesa gotico-catalana di Santa Maria dello Spasimo, mentre nel 2008 il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato ha allestito Dichiaro di essere Emilio Isgrò, seguita nel 2009 da Fratelli d’Italia al Palazzo delle Stelline di Milano. Successivamente, per le celebrazioni dell’Unità d’Italia, la Città di Marsala propone negli spazi del Convento del Carmine la mostra Disobbedisco. Sbarco a Marsala e altre Sicilie, alla quale ha fatto seguito una vasta retrospettiva alla Sanat Galerisi di Istanbul su invito ufficiale della città capitale europea della cultura 2010, mentre la Boghossian Foundation di Bruxelles espone a ruota i quattordici Codici ottomani, riproposti poi dalla Fondazione Marconi di Milano. Nel 2011 La Costituzione cancellata viene presentata alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, e inaugurata nel maggio dello stesso anno, all’Università Bocconi di Milano, l’opera pedagogica Cancellazione del debito pubblico. Nel 2012 un’intera sala del Mart di Rovereto viene dedicata alla sua opera Cancello il Manifesto del Futurismo mentre poco dopo, nel giugno 2013 alla Galleria Nazionale di Arte Moderna viene curata e allestita la sua più significativa retrospettiva. Nel 2014, ancora per il Pecci di Prato, Isgrò è ideatore e protagonista di un progetto in tre tempi dal titolo Maledetti toscani, benedetti italiani che lo ha visto interpretare Curzio Malaparte sul palcoscenico del Teatro Metastasio di Prato, cancellare undici illustri toscani per una mostra al Museo di Palazzo Pretorio e realizzare un video d’artista dal titolo Le api di Lipari. Iniziatore delle “cancellature” di testi, applicate su enciclopedie, manoscritti, libri, mappe e anche su pellicole cinematografiche, Isgrò ha fatto di questa pratica il perno di tutta la sua ricerca, in una sorta di rilettura a rovescio e di reinterpretazione del linguaggio che da verbale si tramuta, attraverso calibrate manipolazioni, in linguaggio visuale. “La cancellatura” dice l’artista “non è una banale negazione ma piuttosto l’affermazione di nuovi significati: è la trasformazione di un segno negativo in gesto positivo". Artista dell’Anno di Radio3 per il 2014, Emilio Isgrò dal 1956 a oggi vive e lavora a Milano, salvo una parentesi a Venezia (1960-1967) come responsabile delle pagine culturali del Gazzettino. Nel maggio del 2014 la Galleria degli Uffizi di Firenze ha accolto il suo autoritratto del 1971 Dichiaro di non essere Emilio Isgrò. Una significativa scelta dei suoi scritti teorici è stata pubblicata nel 2007 da Skira con il titolo La cancellatura e altre soluzioni e integrata nel 2013 da Maretti con il testo Come difendersi dall’arte e dalla pioggia.